|
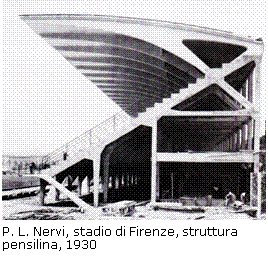 Pier Luigi Nervi nacque a Sondrio il 21 giugno 1891. Il suo prestigioso nome è indissolubilmente legato alla ricerca ingegneristica sulle possibilità delle strutture in cemento armato. Dopo essersi laureato in ingegneria civile presso la regia Scuola di applicazione di Bologna, comincia a lavorare nella Società Anonima per Costruzioni Cementizie diretta dal suo professore di architettura tecnica Attilio Muggia, che inoltre era concessionario nell’Italia centrale del brevetto per il cemento armato Hennebique. La guerra interruppe ben presto il suo tirocinio e Nervi dovette prestare servizio nel Genio Militare dal 1915 al 1918. Nonostante le difficoltà di questi anni fossero molte e gravi, egli non smise di sperimentare e di ragionare per risolvere i problemi che la vita militare gli presentava ogni giorno, facendosi notare per una serie di brillanti invenzioni che culminarono con l’idea di un motore ad idrogeno per siluri. Terminata la guerra, quando le armi furono deposte e gli eserciti congedati, il giovane riprese a lavorare per la Società e fu presto assegnato alla sede di Firenze, dove si distinse subito per il raffinato ingegno e l’abilità nel dirigere i lavori in cantiere. Le responsabilità crescevano di pari passo con la scoperta delle sue doti. Così, anche grazie a queste prime esperienze sul campo, in pochi anni il neo ingegnere diventò un professionista maturo e autonomo. Nel 1923 le restrizioni della guerra erano ormai lontane e Nervi, in procinto di sposarsi, decise di lasciare il suo posto da dipendente per trasferirsi a Roma e fondare una propria società in collaborazione con l’imprenditore e, al momento, unico finanziatore dell’attività, Rodolfo Nebbiosi. Finalmente libero di sperimentare e ottimizzare le soluzioni compositive e strutturali, Nervi creò in questi anni le sue prime e originali coperture a grande luce: in particolare, il Politeama Bruno Banchini a Prato del 1923-’25 e il teatro Augusteo a Napoli del 1926-’29. Pier Luigi Nervi nacque a Sondrio il 21 giugno 1891. Il suo prestigioso nome è indissolubilmente legato alla ricerca ingegneristica sulle possibilità delle strutture in cemento armato. Dopo essersi laureato in ingegneria civile presso la regia Scuola di applicazione di Bologna, comincia a lavorare nella Società Anonima per Costruzioni Cementizie diretta dal suo professore di architettura tecnica Attilio Muggia, che inoltre era concessionario nell’Italia centrale del brevetto per il cemento armato Hennebique. La guerra interruppe ben presto il suo tirocinio e Nervi dovette prestare servizio nel Genio Militare dal 1915 al 1918. Nonostante le difficoltà di questi anni fossero molte e gravi, egli non smise di sperimentare e di ragionare per risolvere i problemi che la vita militare gli presentava ogni giorno, facendosi notare per una serie di brillanti invenzioni che culminarono con l’idea di un motore ad idrogeno per siluri. Terminata la guerra, quando le armi furono deposte e gli eserciti congedati, il giovane riprese a lavorare per la Società e fu presto assegnato alla sede di Firenze, dove si distinse subito per il raffinato ingegno e l’abilità nel dirigere i lavori in cantiere. Le responsabilità crescevano di pari passo con la scoperta delle sue doti. Così, anche grazie a queste prime esperienze sul campo, in pochi anni il neo ingegnere diventò un professionista maturo e autonomo. Nel 1923 le restrizioni della guerra erano ormai lontane e Nervi, in procinto di sposarsi, decise di lasciare il suo posto da dipendente per trasferirsi a Roma e fondare una propria società in collaborazione con l’imprenditore e, al momento, unico finanziatore dell’attività, Rodolfo Nebbiosi. Finalmente libero di sperimentare e ottimizzare le soluzioni compositive e strutturali, Nervi creò in questi anni le sue prime e originali coperture a grande luce: in particolare, il Politeama Bruno Banchini a Prato del 1923-’25 e il teatro Augusteo a Napoli del 1926-’29.
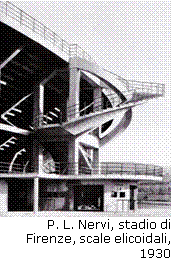 Nel 1930, dopo il successo che l’elegante palazzina del lungotevere Arnaldo da Brescia (costruita su progetto dell’architetto Capponi) riscosse tra la critica, Nervi iniziò la progettazione dello Stadio di Firenze. Quando i lavori in cantiere presero avvio, l’ingegnere decise di sciogliere la società che gestiva insieme a Nebbiosi per avviarne una più autonoma a conduzione familiare. Così, nel 1932, fondò la Nervi & Bartoli in collaborazione con il cugino. Lo stadio fiorentino fu la prima grande opera riconosciuta con enorme favore dalla critica nazionale e internazionale. L’energico slancio della pensilina sopra la tribuna e il sinuoso intreccio degli scaloni di accesso divennero il simbolo delle potenzialità plastiche che il cemento armato conferiva alle architetture. Supportato dall’ormai ventennale esperienza nel campo delle costruzioni cementizie, Nervi fu in grado di sfruttare al meglio le capacità di resistenza di questo materiale, riducendo al minimo le sezioni e indirizzando il carico strutturale secondo percorsi sapientemente calcolati. Il risultato fu sorprendente. La pensilina sembra quasi sagomata dal vento: rinforzata da ventiquattro nervature, si libra a mezz’aria come l’ala di un uccello grazie al contrappeso stabilizzante del corpo delle gradinate e all’azione del puntone che, mimetizzato nel profilo aerodinamico, ne dimezza lo sbalzo. Il machiavellico sistema studiato per le scale che danno accesso alle tribune scoperte è analogamente basato sul contrappeso delle strutture. Le rampe di scalini sporgono come mensole da una trave avvolta a spirale che a metà del suo sviluppo in altezza si interseca con una trave simmetrica: questa, oltre a rendere perfettamente proporzionato il disegno complessivo, ha il fondamentale ruolo statico di ridurre l’azione torcente generata dall’intricato disegno nella trave elicoidale principale. Nel 1930, dopo il successo che l’elegante palazzina del lungotevere Arnaldo da Brescia (costruita su progetto dell’architetto Capponi) riscosse tra la critica, Nervi iniziò la progettazione dello Stadio di Firenze. Quando i lavori in cantiere presero avvio, l’ingegnere decise di sciogliere la società che gestiva insieme a Nebbiosi per avviarne una più autonoma a conduzione familiare. Così, nel 1932, fondò la Nervi & Bartoli in collaborazione con il cugino. Lo stadio fiorentino fu la prima grande opera riconosciuta con enorme favore dalla critica nazionale e internazionale. L’energico slancio della pensilina sopra la tribuna e il sinuoso intreccio degli scaloni di accesso divennero il simbolo delle potenzialità plastiche che il cemento armato conferiva alle architetture. Supportato dall’ormai ventennale esperienza nel campo delle costruzioni cementizie, Nervi fu in grado di sfruttare al meglio le capacità di resistenza di questo materiale, riducendo al minimo le sezioni e indirizzando il carico strutturale secondo percorsi sapientemente calcolati. Il risultato fu sorprendente. La pensilina sembra quasi sagomata dal vento: rinforzata da ventiquattro nervature, si libra a mezz’aria come l’ala di un uccello grazie al contrappeso stabilizzante del corpo delle gradinate e all’azione del puntone che, mimetizzato nel profilo aerodinamico, ne dimezza lo sbalzo. Il machiavellico sistema studiato per le scale che danno accesso alle tribune scoperte è analogamente basato sul contrappeso delle strutture. Le rampe di scalini sporgono come mensole da una trave avvolta a spirale che a metà del suo sviluppo in altezza si interseca con una trave simmetrica: questa, oltre a rendere perfettamente proporzionato il disegno complessivo, ha il fondamentale ruolo statico di ridurre l’azione torcente generata dall’intricato disegno nella trave elicoidale principale.
Negli anni successivi Nervi continuò a lavorare senza sosta ma, poiché era anche un accanito sperimentatore, intrattenne rapporti con i giovani architetti razionalisti e partecipò a molte delle loro iniziative, pubblicando i progetti più avveniristici sulle riviste d’avanguardia. Appartengono a questa fase gli studi per l’albergo galleggiante dotato di un dispositivo (brevettato!) che lo rende insensibile al moto ondoso, la palazzina girevole che segue il movimento del sole e il monumento alla bandiera, una torre alta 250 metri stabilizzata da un pesante pendolo interno. Nel febbraio del 1939 fu pubblicato il bando del concorso per la costruzione del Palazzo dell’acqua e della luce all’E42, che si sarebbe svolta a Roma lo stesso anno. Premettendo che non vi furono vincitori, il progetto di Nervi guadagnò il secondo premio a pari merito con una coppia di ar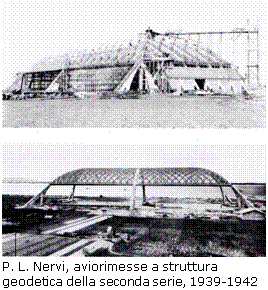 chitetti. Ai tre fu richiesto di elaborare insieme un nuovo progetto, ma l’ingegnere non accettò l’invito e la seconda Guerra Mondiale sospese ben presto l’operazione. Tra le diverse versioni studiate per questo concorso, quella presentata alla giuria configura un edificio ad elica, avvolto intorno ad un’alta torre-fontana e sollevato dal suolo da pochi arditi piloni: il percorso espositivo, sviluppato lungo il nastro in ascensione, sarebbe terminato in una terrazza panoramica. chitetti. Ai tre fu richiesto di elaborare insieme un nuovo progetto, ma l’ingegnere non accettò l’invito e la seconda Guerra Mondiale sospese ben presto l’operazione. Tra le diverse versioni studiate per questo concorso, quella presentata alla giuria configura un edificio ad elica, avvolto intorno ad un’alta torre-fontana e sollevato dal suolo da pochi arditi piloni: il percorso espositivo, sviluppato lungo il nastro in ascensione, sarebbe terminato in una terrazza panoramica.
Nonostante i molti riconoscimenti e l’ormai consolidato successo internazionale, si avvicinavano anni molto difficili per un progettista e costruttore che, come Nervi, fosse specializzato nel cemento armato. Nel 1935, dopo la guerra d’Etiopia, la Società delle Nazioni impose dure sanzioni per l’Italia, vietando a qualsiasi Stato di vendere al nostro Paese materiali potenzialmente utilizzabili dall’industria bellica, metalli in particolare. Così, il regime ne approfittò per promuovere l’autarchia: nel 1937 il cemento armato fu classificato come non abbastanza “italico” e dal 1939 fu addirittura proibito. La modesta produzione nazionale di acciaio fu destinata in esclusiva agli armamenti e il mondo delle costruzioni dovette rinunciare al tondino di armatura e, di conseguenza, al cemento armato. Nonostante ciò, come già era accaduto ai tempi del servizio militare, le difficoltà stimolarono l’ingegno e la sperimentazione dell’astuto Nervi non conobbe sosta: l’occasione per rinnovare completamente la tecnica per le costruzioni cementizie gli fu inconsapevolmente offerta dalla Regia Aeronautica militare, che naturalmente aveva il permesso di utilizzare anche i materiali proibiti e necessitava di numerose aviorimesse per proteggere gli stormi in vista del conflitto. Libero da ogni vincolo, Nervi elaborò un nuovo tipo edilizio studiato per poter essere ripetuto identico in molti campi di volo, riducendo in questo modo i tempi di costruzione. La prima coppia di aviorimesse a struttura geodetica fu realizzata ad Orvieto tra il 1935 e il 1938, ma in questo caso il cemento armato fu ancora gettato in opera. Nel 1939, con la realizzazione della 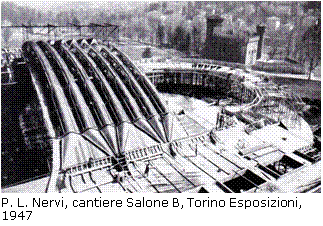 seconda coppia di aviorimesse realizzata nei pressi degli idroscali di Orbetello e di Torre del Lago Puccini, Nervi inventò e brevettò un nuovo sistema costruttivo: la “prefabbricazione strutturale”. Questa pratica semplice, efficiente ed applicabile ad ogni soluzione tipologica (meglio se con qualche asse di simmetria) permise di realizzare strutture monolitiche con grande risparmio di tempo e materiali. L’idea fu quella di scomporre la struttura in piccoli moduli leggeri e maneggevoli da trasportare e da montare. I pezzi venivano preparati a terra, sotto tettoie che proteggevano dalle intemperie, collocati nella loro posizione definitiva tramite ferri di attesa sporgenti e infine collegati attraverso il getto in opera eseguito con cemento ad alta resistenza. Sebbene il sistema costruttivo della prima coppia di aviorimesse fosse molto differente dall’innovativa prefabbricazione della seconda coppia, la forma delle quattro gigantesche strutture era praticamente identica: furono concepite come grandi volte reticolari a padiglione, formate dall’incrocio di un doppio sistema di archi uguali e sollevate dal terreno tramite piloni fortemente inclinati. Erano alte da 12 a 20 metri e coprivano una superficie pari a quella di un campo da calcio. Purtroppo nessuna di queste aviorimesse si è conservata, poiché furono bombardate dagli Alleati o demolite dalle barbariche ritirate delle truppe naziste durante la seconda Guerra Mondiale. seconda coppia di aviorimesse realizzata nei pressi degli idroscali di Orbetello e di Torre del Lago Puccini, Nervi inventò e brevettò un nuovo sistema costruttivo: la “prefabbricazione strutturale”. Questa pratica semplice, efficiente ed applicabile ad ogni soluzione tipologica (meglio se con qualche asse di simmetria) permise di realizzare strutture monolitiche con grande risparmio di tempo e materiali. L’idea fu quella di scomporre la struttura in piccoli moduli leggeri e maneggevoli da trasportare e da montare. I pezzi venivano preparati a terra, sotto tettoie che proteggevano dalle intemperie, collocati nella loro posizione definitiva tramite ferri di attesa sporgenti e infine collegati attraverso il getto in opera eseguito con cemento ad alta resistenza. Sebbene il sistema costruttivo della prima coppia di aviorimesse fosse molto differente dall’innovativa prefabbricazione della seconda coppia, la forma delle quattro gigantesche strutture era praticamente identica: furono concepite come grandi volte reticolari a padiglione, formate dall’incrocio di un doppio sistema di archi uguali e sollevate dal terreno tramite piloni fortemente inclinati. Erano alte da 12 a 20 metri e coprivano una superficie pari a quella di un campo da calcio. Purtroppo nessuna di queste aviorimesse si è conservata, poiché furono bombardate dagli Alleati o demolite dalle barbariche ritirate delle truppe naziste durante la seconda Guerra Mondiale.
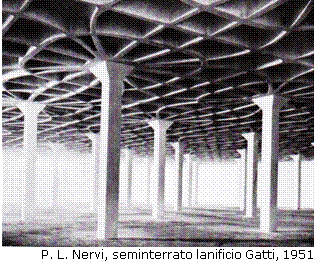 Nei mesi successivi le vicende internazionali precipitarono velocemente: nell’estate del 1940 la guerra era scoppiata e il blocco delle costruzioni impedì a Nervi di sperimentare il nuovo brevetto in altre strutture. Ma l’instancabile mente dell’ingegnere non smise di lavorare: ragionando sull’impossibilità di reperire grosse quantità di cemento poiché il materiale era stato proibito dal regime autarchico, Nervi giunse ad inventare un’insolita variante del materiale edilizio, che brevettò nell’aprile del 1943, il “ferrocemento”. Mentre il cemento armato ordinario è composto da molto conglomerato cementizio e poco acciaio, nel ferrocemento le proporzioni tra i due componenti erano invertite. Il metodo consisteva nel preparare un pacchetto di reti di acciaio disposte in file serrate che venivano ricoperte di conglomerato; il composto era poi spalmato con la cazzuola fino a saturare il feltro metallico e, una volta emerso dall’altro lato, era infine lisciato. La soletta che si otteneva in questo modo, di spessore molto sottile (in genere appena 3 centimetri), si dimostrò resistentissima, elastica, flessibile e molto economica. Naturalmente, per essere utilizzabile nelle costruzioni edilizie, il ferrocemento doveva essere plasmato in forme adeguate e diventare “resistente per forma”: proprio come un sottile foglio di carta c Nei mesi successivi le vicende internazionali precipitarono velocemente: nell’estate del 1940 la guerra era scoppiata e il blocco delle costruzioni impedì a Nervi di sperimentare il nuovo brevetto in altre strutture. Ma l’instancabile mente dell’ingegnere non smise di lavorare: ragionando sull’impossibilità di reperire grosse quantità di cemento poiché il materiale era stato proibito dal regime autarchico, Nervi giunse ad inventare un’insolita variante del materiale edilizio, che brevettò nell’aprile del 1943, il “ferrocemento”. Mentre il cemento armato ordinario è composto da molto conglomerato cementizio e poco acciaio, nel ferrocemento le proporzioni tra i due componenti erano invertite. Il metodo consisteva nel preparare un pacchetto di reti di acciaio disposte in file serrate che venivano ricoperte di conglomerato; il composto era poi spalmato con la cazzuola fino a saturare il feltro metallico e, una volta emerso dall’altro lato, era infine lisciato. La soletta che si otteneva in questo modo, di spessore molto sottile (in genere appena 3 centimetri), si dimostrò resistentissima, elastica, flessibile e molto economica. Naturalmente, per essere utilizzabile nelle costruzioni edilizie, il ferrocemento doveva essere plasmato in forme adeguate e diventare “resistente per forma”: proprio come un sottile foglio di carta c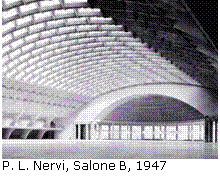 he, se plissettato e piegato ad origami, diventa resistente e capace di sostenere un peso. he, se plissettato e piegato ad origami, diventa resistente e capace di sostenere un peso.
Nel settembre del 1943, subito dopo la firma dell’armistizio, i nazisti invasero Roma e Nervi chiuse l’impresa per non essere costretto a collaborare. Nei tanti mesi di inattività coatta l’ingegnere perfezionò la sua ultima invenzione e, non appena la guerra finì, la Nervi & Bartoli riaprì i battenti con un nuovo brevetto pronto per la sperimentazione. Per verificare le capacità del nuovo materiale fu immediatamente realizzato un piccolo magazzino tutto in ferrocemento le cui pareti, spesse tre centimetri, furono sagomate ad onde per garantirne la stabilità.
L’attività professionale riprese lentamente, secondo il ritmo incerto dell’economica postbellica; ma in un paese dove molto era stato distrutto, la mente brillante e propositiva di Nervi e le sue infallibili invenzioni, furono preziosi strumenti al servizio della Ricostruzione.
Nel 1947 giunse finalmente l’occasione per sfruttare le potenzialità del ferrocemento in una grande opera, il Salone B a Torino Esposizioni. Lo spazio, inaugurato nel settembre del 1948 in occasione della XXXI edizione del Salone dell’automobile, fu realizzato in appena dieci mesi grazie all’innovativo 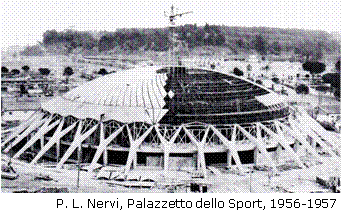 metodo della “prefabbricazione strutturale” e alle caratteristiche del nuovo materiale edilizio. L’impianto del salone è di tipo basilicale: una navata centrale voltata, con camminamenti laterali sopraelevati e chiusa da un’abside semicircolare coperto da semicupola nervata. La suggestiva volta a botte molto appiattita è composta dall’accostamento di onde in ferrocemento, spesse pochi centimetri, raccordate trasversalmente da diaframmi. Nei fianchi delle onde furono ritagliati dei finestroni in modo da consentire il passaggio della luce che inonda il Salone dall’alto. Ogni tre onde un ventaglio raccoglie le spinte e le trasmette ad un pilone inclinato che si allarga fino a terra e in fondazione, conferendo così quella “resistenza per forma” necessaria alle sottili strutture di ferrocemento. La particolare soluzione costruttiva ha consentito di realizzare un singolare ampliamento della volta nel 1952: furono aggiunte nuove onde identiche alle originali, trasformando lo spazio da quadrato a rettangolare. Nel 2006, durante le Olimpiadi invernali di Torino, l’edificio è stato nuovamente riadattato per ospitare le gare di hockey sul ghiaccio ed è oggi tornato, completamente restaurato, alla sua originaria funzione espositiva. metodo della “prefabbricazione strutturale” e alle caratteristiche del nuovo materiale edilizio. L’impianto del salone è di tipo basilicale: una navata centrale voltata, con camminamenti laterali sopraelevati e chiusa da un’abside semicircolare coperto da semicupola nervata. La suggestiva volta a botte molto appiattita è composta dall’accostamento di onde in ferrocemento, spesse pochi centimetri, raccordate trasversalmente da diaframmi. Nei fianchi delle onde furono ritagliati dei finestroni in modo da consentire il passaggio della luce che inonda il Salone dall’alto. Ogni tre onde un ventaglio raccoglie le spinte e le trasmette ad un pilone inclinato che si allarga fino a terra e in fondazione, conferendo così quella “resistenza per forma” necessaria alle sottili strutture di ferrocemento. La particolare soluzione costruttiva ha consentito di realizzare un singolare ampliamento della volta nel 1952: furono aggiunte nuove onde identiche alle originali, trasformando lo spazio da quadrato a rettangolare. Nel 2006, durante le Olimpiadi invernali di Torino, l’edificio è stato nuovamente riadattato per ospitare le gare di hockey sul ghiaccio ed è oggi tornato, completamente restaurato, alla sua originaria funzione espositiva.
Nel 1951 Nervi progettò la sede industriale per il lanificio Gatti in collaborazione con Carlo Cestelli Guidi. L’ambiente più interessante del complesso è un piccolo seminterrato che, protetto dalla scomoda posizione, conserva una delle prime applicazioni del “solaio a nervature isostatiche”, l’ennesima invenzione dell’ingegnere ligure. L’elegante disegno creato dalle nervature che nascono come getti vegetativi dai tronchi-pilastri non è il risultato di un intento decorativo ma ricalca l’andamento delle linee isostatiche di flessione in una piastra sottoposta a carichi. Nervi elaborò il progetto osservando il comportamento naturale della materia: dispose le nervature seguendo il tracciato isostatico che aveva ricavato dai suoi calcoli, ottenendo così anche la massima funzionalità rispetto a qualunque altra composizione possibile. Il “sistema Nervi” si rivelò indispensabile per realizzare il solaio in cemento armato in tempi relativamente brevi e nella massima economia. Fu preparata una forma, grande quanto un intero campo tra i tronchi-pilastri, disponendo secondo il disegno formato dalle linee isostatiche delle scatole cave e senza fondo dal profilo arrotondato, confezionate grazie alla plasmabilità del ferrocemento. Questa forma quadrata, montata su di un carrello, fu riutilizzata in modo da contenere il getto del cemento armato per tutti i riquadri, generando infine il capriccioso arabesco dettato dalla saggezza della natura.
Nella seconda metà degli anni Cinquanta Nervi fu completamente assorbito dal suo lavoro. In questo periodo, infatti, si concentrarono la maggior parte dei progetti che lo resero uno dei più grandi architetti del XX secolo. Due esempi tra tutti sono la sede dell’Unesco a Parigi (realizzata in cooperazione con Marcel Breur e Bernard H. Zehrfuss) e la soluzione messa a punto insieme ad Arturo Danusso per risolvere i problemi strutturali del grattacielo Pirelli, il cui progetto architettonico si deve a Gio Ponti.
Nel 1956 cominciarono anche i lavori per il celebre Palazzetto dello Sport, costruito in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960. La struttura appare come il tendone di un circo, gonfio e trattenuto in tensione grazie a trentasei pilastri radiali inclinati, sui quali il morbido bordo festonato sembra delicatamente adagiato. La liscia calotta esterna appare ancora più riconoscibile all’interno, dove un ricamo di nervature incrociate disegna grandi rombi che si susseguono creando un gioco ottico avvo lgente e suggestivo. Il Palazzetto dello Sport segnò una tappa cruciale nella carriera di Nervi poiché fu l’espressione più matura e completa della sua sperimentazione statica, costruttiva e architettonica, suggellando il definitivo riconoscimento del suo originale sistema di costruzione. Nei pochi anni che intercorsero tra l’assegnazione degli incarichi e l’inaugurazione dei giochi, Nervi e la sua impresa realizzarono altre tre celebri strutture: il Palazzo dello Sport all’Eur, coperto da una cupola del diametro di 100 metri; lo Stadio Flaminio con la svettante pensilina, progettato insieme al figlio Antonio; il viadotto di Corso Francia, che serviva come collegamento diretto tra i campi sportivi e il villaggio degli atleti. Questi progetti gli valsero la Royal Gold Medal, il premio più ambito nel campo dell’architettura, che negli anni immediatamente precedenti era stata vinta da le Corbusier, Walter Gropius, Alvar Aalto e Mies Van der Rohe. lgente e suggestivo. Il Palazzetto dello Sport segnò una tappa cruciale nella carriera di Nervi poiché fu l’espressione più matura e completa della sua sperimentazione statica, costruttiva e architettonica, suggellando il definitivo riconoscimento del suo originale sistema di costruzione. Nei pochi anni che intercorsero tra l’assegnazione degli incarichi e l’inaugurazione dei giochi, Nervi e la sua impresa realizzarono altre tre celebri strutture: il Palazzo dello Sport all’Eur, coperto da una cupola del diametro di 100 metri; lo Stadio Flaminio con la svettante pensilina, progettato insieme al figlio Antonio; il viadotto di Corso Francia, che serviva come collegamento diretto tra i campi sportivi e il villaggio degli atleti. Questi progetti gli valsero la Royal Gold Medal, il premio più ambito nel campo dell’architettura, che negli anni immediatamente precedenti era stata vinta da le Corbusier, Walter Gropius, Alvar Aalto e Mies Van der Rohe.
Nel 1961 fu organizzata a Torino un’esposizione universale per festeggiare il primo centenario dell’Unità d’Italia: nuovissimi edifici espositivi serviti da avveniristici sistemi di trasporto furono costruiti in un’ampia area attraversata dal Po. Nervi vinse il concorso per progettare e costruire il palazzo che doveva ospitare la mostra più importante dell’intera esposizione, dedicata al tema “L’uomo a lavoro”. La concezione della struttura fu il risultato di uno studio elaborato in collaborazione con il figlio Antonio, che lo affiancava già da alcuni anni nel lavoro, e con Gino Covre, lo strutturista italiano più autorevole in materia di costruzioni metalliche. A causa di alcuni problemi burocratici, che ritardarono di molto l’avvio dei lavori, l’opera colossale (25.000 mq coperti) dovette essere completata in tempi eccezionalmente ridotti: poste le fondamenta, a febbraio del 1960, rimanevano solo dodici mesi per consegnare l’edificio ed allestire la mostra per l’inaugurazione. Nervi e la sua squadra riuscirono a risolvere il complesso problema scomponendo il volume a base quadrata in sedici riquadri autonomi identici, ciascuno formato da un pilastro di cemento armato dalla cui sommità sbalza una raggiera di mensole in acciaio. La velocità con cui avanzarono i lavori fu sorprendente: i pilastroni costruiti direttamente in cantiere e le travi della copertura preparate in officina furono rapidamente montate insieme; contemporaneamente, sul perimetro della struttura, fu costruita la galleria sollevata, strutturalmente del tutto autonoma, con la tecnica del solaio a nervature isostatiche; terminati i pilastri e le raggiere più esterne si cominciò a montare il curtain-wall di facciata, schermato da un fitto brise-soleil. Gio Ponti, responsabile artistico della mostra, lasciò ben visibili i giganteschi elementi a fungo, di grande impatto visivo, valorizzando con un elegante allestimento la grafica sagoma di questi elementi. Il padiglione fu universalmente accolto dalla critica come un “prodigio dell’architettura italiana”.
La stazione per autobus realizzata tra il 1961 e il 1962 a New York, fu la prima opera americana di Nervi. Collocata nel cuore di Manhattan, all’estremità orientale di uno dei ponti più famosi della Grande Mela, questa struttura fu certamente decisiva per l’attribuzione, nel 1964, della AIA Gold Medal, massimo riconoscimento degli architetti americani. In omaggio al limitrofo ponte di acciaio a struttura reticolare, l’ingegnere italiano scelse di realizzare una trama a rete, rivisitata tenendo conto delle qualità plastiche del cemento armato, per la copertura e i muri perimetrali della stazione. I possenti shed del tetto appaiono dall’alto come sette smisurate ali di farfalla, dispiegate rispetto alla spina centrale come se l’intera struttura fosse sul punto di staccarsi da terra e prendere il volo. Molto singolare anche la conformazione dei pilastri, la cui sezione a fiocco si trasforma lungo l’altezza torcendosi su se stessa in un movimento che sembra impossibile per il cemento armato.
Nel 1964 l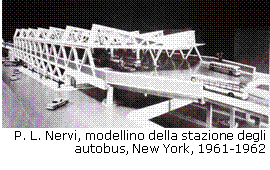 a ditta di Nervi diede avvio alla sua ultima, grandiosa impresa: l’aula delle udienze nella Città del Vaticano. Il prestigioso incarico era stato conferito all’ingegnere da Papa Paolo VI in persona, il quale desiderava un’opera degna di essere fondata all’ombra della basilica di San Pietro. Non una chiesa, non un auditorium, ma il luogo destinato alla udienze pontificie, una sorta di Cappella Sistina moderna, che si configurasse come uno spazio assolutamente nuovo destinato ai fedeli. Nervi riprese tutte le sue più brillanti invenzioni e, migliorandole un’ultima volta, le raccolse in un progetto spettacolare e straordinariamente efficace pur nella sua semplicità ed essenzialità. Sul lotto messo a disposizione, di forma trapezoidale molto allungata, fu costruito un edificio coperto da una grande volta in cemento armato, corrugata da una sequenza interminabile di onde che, adattandosi al trapezio della pianta, confluiscono verso il palco centrale stringendosi e aumentando di altezza, mentre verso il fondo della sala si diradano appiattendosi e allargandosi. La tensione dinamica così generata sembra provenire da un fuoco ideale, collocato proprio nel punto stabilito per sistemare il trono papale. I due isolati pilastroni ritorti, posizionati ai lati del palco, contribuirono alla drammaticità dell’ambiente raccogliendo la spinta di tutte le onde della volta. Ogni elemento della struttura fu realizzato in cemento bianco, con il preciso scopo di lasciare che questo, arricchito solamente da speciali inserti in marmo apuano, assurgesse al rango di materiale prezioso come le pietre e i raffinati a ditta di Nervi diede avvio alla sua ultima, grandiosa impresa: l’aula delle udienze nella Città del Vaticano. Il prestigioso incarico era stato conferito all’ingegnere da Papa Paolo VI in persona, il quale desiderava un’opera degna di essere fondata all’ombra della basilica di San Pietro. Non una chiesa, non un auditorium, ma il luogo destinato alla udienze pontificie, una sorta di Cappella Sistina moderna, che si configurasse come uno spazio assolutamente nuovo destinato ai fedeli. Nervi riprese tutte le sue più brillanti invenzioni e, migliorandole un’ultima volta, le raccolse in un progetto spettacolare e straordinariamente efficace pur nella sua semplicità ed essenzialità. Sul lotto messo a disposizione, di forma trapezoidale molto allungata, fu costruito un edificio coperto da una grande volta in cemento armato, corrugata da una sequenza interminabile di onde che, adattandosi al trapezio della pianta, confluiscono verso il palco centrale stringendosi e aumentando di altezza, mentre verso il fondo della sala si diradano appiattendosi e allargandosi. La tensione dinamica così generata sembra provenire da un fuoco ideale, collocato proprio nel punto stabilito per sistemare il trono papale. I due isolati pilastroni ritorti, posizionati ai lati del palco, contribuirono alla drammaticità dell’ambiente raccogliendo la spinta di tutte le onde della volta. Ogni elemento della struttura fu realizzato in cemento bianco, con il preciso scopo di lasciare che questo, arricchito solamente da speciali inserti in marmo apuano, assurgesse al rango di materiale prezioso come le pietre e i raffinati 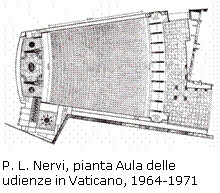 marmi della vicina basilica. marmi della vicina basilica.
Quando l’opera vaticana fu inaugurata, nel 1971, l’ingegner Nervi aveva ormai ottant’anni compiuti e la molta fatica sopportata per realizzare quest’ ultimo, trionfale progetto lo costrinse a ritirarsi dall’impresa familiare. Qualche anno dopo, il 9 gennaio del 1979, morì a Roma, nella palazzina sul lungotevere Arnaldo da Brescia che molto tempo prima aveva inaugurato, ottenendo il primo successo, la sua sfolgorante carriera.
|

