| |
Non fu il comunismo, negli anni tra le due grandi guerre, ad essere l’espressione più radicale della lotta contro l’ordine costituito ma il surrealismo, movimento ideologico–artistico. E probabilmente fu proprio la sua irriducibile radicalità, insieme al fascino comunicativo, a favorirne la larga e capillare diffusione facendolo diventare il più longevo fra le avanguardie storiche rispetto a movimenti invece circoscritti nel tempo e nello spazio come il dadaismo o il futurismo.
 Il surrealismo mosse i suoi primi passi dopo la prima guerra mondiale e il poeta Andrè Breton ne fu l’indiscusso apostolo. Egli fu certamente influenzato dalla lettura de L'interpretazione dei sogni di Freuddel 1899 e, dopo averlo letto, arrivò alla conclusione che era inaccettabile che il sogno e l'inconscio avessero così poco spazio nella civiltà moderna e pensò quindi di fondare questo movimento artistico-letterario-ideologico in cui il sogno e l'inconscio rivestissero un ruolo fondamentale. Il surrealismo mosse i suoi primi passi dopo la prima guerra mondiale e il poeta Andrè Breton ne fu l’indiscusso apostolo. Egli fu certamente influenzato dalla lettura de L'interpretazione dei sogni di Freuddel 1899 e, dopo averlo letto, arrivò alla conclusione che era inaccettabile che il sogno e l'inconscio avessero così poco spazio nella civiltà moderna e pensò quindi di fondare questo movimento artistico-letterario-ideologico in cui il sogno e l'inconscio rivestissero un ruolo fondamentale.
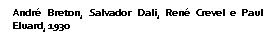 Quest’idea artistico-letteraria in cui l’automatismo delle pulsioni psichiche avrebbe dovuto spazzar via le costruzioni della coscienza chiara, distinta e volontaria, cioè tutto il mondo umano reale, dovette non poco impressionare una certa classe intellettuale che, in un momento storico caratterizzato dall’incertezza e da grandi sconvolgimenti sociali, la colse come l’espressione di una rivoluzione culturale in un’Europa che s’incamminava verso una colossale crisi economico-politica. Quest’idea artistico-letteraria in cui l’automatismo delle pulsioni psichiche avrebbe dovuto spazzar via le costruzioni della coscienza chiara, distinta e volontaria, cioè tutto il mondo umano reale, dovette non poco impressionare una certa classe intellettuale che, in un momento storico caratterizzato dall’incertezza e da grandi sconvolgimenti sociali, la colse come l’espressione di una rivoluzione culturale in un’Europa che s’incamminava verso una colossale crisi economico-politica.
Ben presto il surrealismo assorbì il dadaismo, con il quale aveva mosso i primi passi, fino a farlo scomparire e dimenticare non senza aver prima aggregato il suo stesso promotore, il rumeno Tristan Tzara, figura di un certo rilievo nell’Olimpo della poesia francese contemporanea.
Si potrebbe dire che l’idea surrealista divenne una sorta di naturale evoluzione del dada, perfezionandone la visione nichilista.
Non l’intuizione ma il desiderio illimitato e onnipotente si pone al centro della spinta vitale surrealista: il desiderio ottenebrato e irresistibile dell’oscuro subcosciente nel quale ci si deve ciecamente abbandonate, con totale rinuncia al refoulement freudiano*.
Se l’anarchismo classico partiva dalla convinzione che l’uomo è buono e la costrizione politico- sociale malvagia, il surrealista propugnava l’eliminazione della costrizione ancor più radicalmente dell’anarchico; ma non per lasciar libero il passo alla bontà naturale, bensì al desiderio individuale e preferibilmente a coloro che la morale classifica come malvagi e perciò esposti al refoulement.
Raccapricciante è la frase di Aragon, uno dei fondatori del movimento: Nos hèros sont Violette Nozière** la parricide, le criminel anonyme de droit commun, le sacrilège conscient et raffinèere.
Dunque ciò che anima il surrealista non è aspirare alla felicità umana, ma la volontà di potenza che determina il desiderio contro ogni costrizione, barriera sociale o legge dello stato; la stessa concezione della vita del marchese De Sade, che fu infatti, a dire dello storico e apologeta del surrealismo Nadeau, la figura centrale del Pantheon surrealista.
Contemporaneo al surrealismo fu lo sviluppo, in apparenza puramente politico, del nazionalsocialismo di Adolf Hitler. Se Hitler abbia mai saputo del surrealismo o del marchese De Sade non saprei dire. Ma certamente sono surrealistiche e sadiche le sue confessioni riportate da Hermann Rauschning nel libro Gespräche mit Hitler (Colloqui con Hitler): …..acquisto di una visione magica come scopo dell’evoluzione umana…..Diritto divino ad annientare tutto ciò che dura……Il delitto è l’atto di maggior valore dell’inutilità borghese……noi dobbiamo essere crudeli e avere la coscienza tranquilla…Noi abbiamo il dovere di spopolare.
Questo sadismo mise in atto fin dall’inizio un processo di sublimazione con la pretesa di conquistare una super coscienza, un metodo per il raggiungimento dell’ignoto e dell’inesplorato che è la vera realtà, meglio definita come surrealtà, ubbidendo all’automatismo dell’impulso. Ci si doveva mettere con la penna in mano davanti a un foglio di carta e scrivervi esattamente tutto ciò che veniva alla mente, senza scelta o coordinamento, oppure mettersi con il pennello in mano davanti ad una tela e ricoprirla di segni e colori. La massima attività trovava il suo apogeo nella totale passività del pensiero razionale.
I surrealisti per esprimere questo processo spirituale trovavano formule di autentico sapore quietistico***. Allo stesso modo gli ultra-avveniristi o superfuturisti, senza averne coscienza, si rifacevano ad un misticismo di età barocca.
Il Manifeste du surrèalisme di Andrè Breton nell’autunno del 1924 così definì il surrealismo: Automatismo psichico puro, attraverso il quale ci si propone di esprimere, con le parole o la scrittura o in altro modo, il reale funzionamento del pensiero. Comando del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale.
Dunque annullamento della volontà e della ragione nel completo isolamento dal mondo circostante. Il manifesto interpretava il modello dell’automatismo come una sorta di dettatura del pensiero senza l’influenza esercitata dalla ragione e soprattutto alienandosi da qualsiasi preoccupazione estetico-morale. Non ragionamento, come si è detto, e nemmeno intuizione ma abbandono ad una sorta di meta-pensiero ponendosi come obiettivo una conoscenza superiore, integrale. Più o meno come la visione magica di Adolf Hitler.
 La voce del movimento fu la rivista, comparsa il primo Dicembre 1924, La Rèvolution surrèaliste che pubblicò nei primi numeri stesure automatiche in prosa o in versi, racconti di sogni, inchieste, raccolte di cronaca che sembravano materiale di ricerca e analisi. In una conferenza dell’Aprile 1925 Louis Aragon proclamò: Io non lavorerò mai, le mie mani sono pure. Io maledico la scienza sorella gemella del lavoro, la pigrizia è la sola patria del pensiero autentico. La voce del movimento fu la rivista, comparsa il primo Dicembre 1924, La Rèvolution surrèaliste che pubblicò nei primi numeri stesure automatiche in prosa o in versi, racconti di sogni, inchieste, raccolte di cronaca che sembravano materiale di ricerca e analisi. In una conferenza dell’Aprile 1925 Louis Aragon proclamò: Io non lavorerò mai, le mie mani sono pure. Io maledico la scienza sorella gemella del lavoro, la pigrizia è la sola patria del pensiero autentico.
Una pigrizia che in realtà nascondeva un’azione estrema perché quello stesso anno sentenziò: Noi distruggeremo questa civiltà che vi è cara… Mondo occidentale tu sei condannato a morte.
Il motivo dell’odio verso la civiltà occidentale torna nella lettera aperta del 25 luglio 1925 a Paul Claudel, drammaturgo positivista, che aveva definito “pederastico” il surrealismo: Noi auguriamo con tutte le nostre forze che le rivoluzioni, le guerre e le insurrezioni coloniali distruggano codesta civiltà coloniale i cui pidocchi voi diffondete fino in Oriente.
 Paradossalmente l’idea della rivoluzione per la rivoluzione, della rivoluzione senza fine che compare in certe esplosioni verbali di Mussolini e anche in taluni suoi comportamenti, è presente, molto più decisamente, nel surrealismo. Scriveva ancora Aragon in uno dei primi numeri di Revolution surrèaliste: Io metto lo spirito di rivolta ben al di là di qualsiasi politica. Paradossalmente l’idea della rivoluzione per la rivoluzione, della rivoluzione senza fine che compare in certe esplosioni verbali di Mussolini e anche in taluni suoi comportamenti, è presente, molto più decisamente, nel surrealismo. Scriveva ancora Aragon in uno dei primi numeri di Revolution surrèaliste: Io metto lo spirito di rivolta ben al di là di qualsiasi politica.
Già prima del surrealismo c’era stato chi aveva affermato che la liberazione totale era disfarsi della vita, il suicidio. Il surrealismo prende in seria considerazione questo punto di vista tanto che in un numero della Revolution apre un’inchiesta sul suicidio, che deve rispondere al quesito: Le suicide est une solution? Tra le risposte vi fu quella di Renè Crevel, poeta surrealista che sosteneva questa, il suicidio, la giusta e definitiva soluzione. Dopo dieci anni Crevel la applicava suicidandosi con il gas della sua cucina. Ma forse giunse a questa estrema soluzione perché depresso dalle severe critiche che ricevevano i suoi lavori.
Pur tuttavia il suicidio rimaneva il punto di arrivo del surrealismo e, a dispetto di ogni logica, la tendenza distruttiva non poteva essere eliminata dal surrealismo come non lo era stata precedentemente dal nichilismo e dall’anarchia.
A questo punto era inevitabile che il surrealismo s’incontrasse con il comunismo, dal momento che questo era, il quello specifico contesto storico, il principale movimento di rivolta contro l’ordine politico-sociale esistente e quello ideologico-religioso.
I surrealisti rivolsero anche un appello al Dahlai-Lama del Tibet ma non arrivò mai nessuna risposta, nessuna ispirazione. Nell’Asia, che i surrealisti definivano “cittadella di tutte le speranze” adesso si incontrava anche il bolscevismo.
 L’approccio al comunismo si ebbe, dopo un iniziale diffidente riserva, attraverso l’alleanza con la rivista Clartè**** e con altri gruppi antiborghesi più piccoli. Ne venne fuori il manifesto del 1925 La Revolution d’abord et toujours (Rivoluzione prima e sempre) dei cui firmatari il gruppo più numeroso è quello surrealista. Esso snoda i motivi della liberazione totale, dell’isteria patriottica, della civiltà occidentale antiumana per poi riannodandoli intorno al ripudio dell’ordinamento economico–sociale approdando infine al disarmo e all’antimilitarismo rivoluzionari, alla ferma condanna della guerra al Marocco, al rifiuto del patriottismo degli intellettuali, terminando col proclamare: cette revolution nous ne la concervons que sous sa forme sociale. Il termine comunismo e l’URSS non figuravano: si parlava solo di occhi rivolti all’Asia. L’approccio al comunismo si ebbe, dopo un iniziale diffidente riserva, attraverso l’alleanza con la rivista Clartè**** e con altri gruppi antiborghesi più piccoli. Ne venne fuori il manifesto del 1925 La Revolution d’abord et toujours (Rivoluzione prima e sempre) dei cui firmatari il gruppo più numeroso è quello surrealista. Esso snoda i motivi della liberazione totale, dell’isteria patriottica, della civiltà occidentale antiumana per poi riannodandoli intorno al ripudio dell’ordinamento economico–sociale approdando infine al disarmo e all’antimilitarismo rivoluzionari, alla ferma condanna della guerra al Marocco, al rifiuto del patriottismo degli intellettuali, terminando col proclamare: cette revolution nous ne la concervons que sous sa forme sociale. Il termine comunismo e l’URSS non figuravano: si parlava solo di occhi rivolti all’Asia.
In questa fase il surrealismo aveva cercato un’alleanza, da pari a pari, con il comunismo. Si potrebbe dire che in un qualche modo il movimento aspirasse a fornirgli un’ideologia e ad esserne la mente direttiva. Ma il comunismo sovietico l’ideologia c’è l’aveva eccome e relativo cervello; essa andava in una direzione ben diversa da quella dell’individualismo anarchico dei surrealisti, ed era animata da uno spirito ben diverso perchè considerava l’intellettualismo un nemico mortale della rivoluzione. Al comunismo non interessava affatto l’indagine del subcosciente, l’automatismo psichico, la liberazione dalla logica occidentale, nemmeno la rivoluzione permanente ed illimitata. Al contrario, bandiva ogni spirito di rivolta individuale e mirava a una costruzione, nuova sì, ma che utilizzasse gli strumenti forniti dalla società precedente, dunque dalla civiltà occidentale, una costruzione che doveva essere precisa, definitiva e obbligatoria.
Che cosa poteva giovare a Breton, d’innanzi a questa irremovibile realtà, accettare il programma sovietico o porre il surrealismo al servizio della rivoluzione bolscevica? A nulla. Pur tuttavia Breton benchè consapevole che il suo principio di potenza assoluta della contraddizione, insieme al desiderio di autonomia, non erano compatibili con i comunisti europei e tanto meno con Mosca accettò lo stesso un improbabile compromesso.
Ma ad un certo punto avvenne l’inevitabile divisione. Chi voleva a tutti i costi incorporarsi con il partito comunista uscì dal movimento. Avvenne così lo scisma di Aragon del 1931 che tuttavia non danneggiò gran che il movimento, che anzi si rinforzò di nuovi adepti. La rottura tra essi ed il partito comunista francese divenne completa quando alla fine del 1933 Breton ed Eluard furono espulsi dal partito. Tuttavia essi continuarono ad occuparsi di politica formando un gruppo di estrema sinistra ma senza particolare rilievo. Si verificò però la rottura tra l’azione politica e quella artistica; questo divorzio consumato all’interno del movimento ne favorì la decadenza e la dissoluzione.
Il movimento surrealista, nel suo breve periodo di storia, ritrae con perfetto realismo le condizioni mentali e morali di una parte della classe intellettuale occidentale: confusione di idee, sterilità di sentimenti, atrofizzazione o addirittura perversione della coscienza morale, perdita del senso della realtà. Il pensiero si trasforma gioco, la volontà reazione isterica. Per i più il surrealismo si è espresso soprattutto con pittura e certamente Salvador Dalì ne è stato un geniale interprete, tuttavia molto prima la pittura metafisica italiana, il cui caposcuola era stato Giorgio de Chirico, già sperimentava ciò che vi è oltre l'apparenza fisica e oltre l'esperienza dei sensi. Mark Chagall già dipingeva nel 1912 il mondo surreale dell’inconscio e vi tornò più tardi negli anni 30 con le sue fantasie di sogni bizzarri e paurosi. Nella poesia il movimento surrealista non ha creato quasi nulla; ha teorizzato posizioni intellettuali preesistenti che hanno continuato ad esistere parallelamente alle pubblicazioni surrealiste. In letteratura, L’Ulisse di Joyce, pubblicato nel 1922 ma scritto nel 1914, realizza in anticipo l’automatismo surrealistico nei monologhi interiori dei suoi personaggi che esistono unicamente per se stessi: balbettii confusi e interminabili, inseriti monotonamente uno dietro l’altro senza interesse nè senso, senza capo nè coda. Insomma ancor prima che Breton e compagni componessero i loro manuali, il mondo della cultura e dell’arte già sondava e sperimentava, con fini certamente più costruttivi, i misteriosi percorsi dell’inconscio.
*Termine psicoanalitico che indica un meccanismo mentale di difesa contro le idee che sono incompatibili con l'ego.
** Il 28 agosto 1933 venne arrestata dalla polizia con l'accusa di avere avvelenato i propri genitori con del Soménal, un sonnifero. La madre riuscì a salvarsi, ma il padre morì. Fu condannata a morte per parricidio nel 1934.
***Il Quietismo è una dottrina mistica che ha lo scopo di indicare la strada verso Dio consistente in uno stato di quiete passiva e fiduciosa dell’anima.
****Clartè: rivista comunista diretta da Pierre Naville.
|

