| |
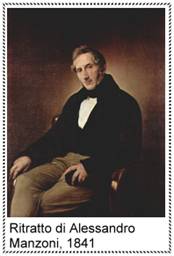 Il 7 marzo 1785 nacque a Milano Alessandro Manzoni. Il figlio di un nobile milanese e di Giulia Beccaria, nipote quindi del grande illuminista lombardo Cesare, sarebbe diventato uno dei più importanti romanzieri della storia d’Italia. Manzoni, con i suoi Promessi Sposi, diede un contributo fondamentale alla letteratura nazionale italiana, sia per aver scelto un genere fino ad allora sconosciuto alla nostra tradizione letteraria, cioè il romanzo storico, sia per il lavoro di ricerca linguistica, che dilatò di molto il tempo di gestazione dell’opera. Infatti la prima edizione, intitolata “Fermo e Lucia”, risale al 1821. Solo nel 1841 Manzoni pubblicò i Promessi Sposi dopo aver “ripulito i panni in Arno” e aver perfezionato il lavoro di indagine storica, nel quale inserì perfettamente la vicenda fantastica da lui inventata, come fino ad allora avevano fatto solo alcuni grandi autori stranieri, fra cui Walter Scott fu il primo, con il suo “Ivanoe”. Il 7 marzo 1785 nacque a Milano Alessandro Manzoni. Il figlio di un nobile milanese e di Giulia Beccaria, nipote quindi del grande illuminista lombardo Cesare, sarebbe diventato uno dei più importanti romanzieri della storia d’Italia. Manzoni, con i suoi Promessi Sposi, diede un contributo fondamentale alla letteratura nazionale italiana, sia per aver scelto un genere fino ad allora sconosciuto alla nostra tradizione letteraria, cioè il romanzo storico, sia per il lavoro di ricerca linguistica, che dilatò di molto il tempo di gestazione dell’opera. Infatti la prima edizione, intitolata “Fermo e Lucia”, risale al 1821. Solo nel 1841 Manzoni pubblicò i Promessi Sposi dopo aver “ripulito i panni in Arno” e aver perfezionato il lavoro di indagine storica, nel quale inserì perfettamente la vicenda fantastica da lui inventata, come fino ad allora avevano fatto solo alcuni grandi autori stranieri, fra cui Walter Scott fu il primo, con il suo “Ivanoe”.
L’importanza letteraria e storica dei Promessi non è in discussione. Qui proveremo a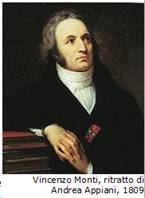 capire come il Manzoni abbia sviluppato la sua idea di letteratura e come la vicenda umana dell’autore abbia prima favorito la sua crescita di scrittore e poi determinato la fine del suo periodo creativo. Gli anni di maturità del Manzoni furono funestati da crisi nevrotiche, tensioni famigliari dovute a diversi lutti e al comportamento dei figli maschi, che si impegnavano a sperperare il patrimonio paterno, ma soprattutto dal rifiuto non solo della poesia, ma sembrerebbe piuttosto del suo stesso genio. capire come il Manzoni abbia sviluppato la sua idea di letteratura e come la vicenda umana dell’autore abbia prima favorito la sua crescita di scrittore e poi determinato la fine del suo periodo creativo. Gli anni di maturità del Manzoni furono funestati da crisi nevrotiche, tensioni famigliari dovute a diversi lutti e al comportamento dei figli maschi, che si impegnavano a sperperare il patrimonio paterno, ma soprattutto dal rifiuto non solo della poesia, ma sembrerebbe piuttosto del suo stesso genio.
Per fare questo ci affideremo all’analisi dei rapporti epistolari intrattenuti dal Manzoni con tre diversi personaggi, che in momenti e modi differenti hanno determinato la crescita e lo sviluppo di una teoria letteraria matura e capiremo la difficoltà di convivere con i propri demoni, vissuta da uno degli autori più importanti, e sicuramente più studiati, della storia del nostro paese.
Nel 1801 Manzoni terminò gli studi superiori presso i collegi dei frati Somaschi e poi dei monaci Barnabiti, dove era stato mandato da suo padre Pietro. Ritornato a Milano, il giovane Alessandro entrò subito in contatto con alcuni dei più famosi letterati del tempo e si dedicò alla poesia. Tra questi importanti autori conosciuti dal Manzoni ci fu Vincenzo Monti, poeta ed accademico, che in quegli anni lavorava presso l’università di Pavia e con il quale Manzoni intrattenne una fitta corrispondenza. Il rapporto tra i due fu quello dell’allievo e del maestro: Manzoni chiedeva al Monti consigli per migliorare il proprio linguaggio poetico e il suo interlocutore lo spingeva a coltivare il suo magnifico talento, fiducioso nelle capacità straordinarie del giovane poeta, al quale consigliava di affinare la parola, senza perdere la capacità di colpire il lettore, grazie a spunti satirici e giochi stilistici.
Risale a questo periodo la poesia “Trionfi della Libertà”, dove Manzoni, nonostante la giovane età, mostra il genio che lo renderà immortale. La poesia infatti, oltre ad essere stilisticamente valida è arricchita da un contenuto tagliente, e si scaglia contro le forze che attanagliano la penisola chiedendo alle muse di ridare forza all’arte poetica italiana. Anni dopo, quando Manzoni rileggerà questi versi, non li disconoscerà, ritrovando elementi cari a tutta la sua produzione letteraria, ma definirà “folle ingegno giovanile” quello del quindicenne che pretende di salvare la poesia.
Nel 1803 scrisse Adda, un idillio che inviò al Monti allegando insieme all’opera questa missiva:
«Voi mi avete più volte ripreso di poltrone, e lodato di buon poeta. Per farvi vedere ch'io non sono né l'uno né l'altro, vi mando questi versi. Ma il principale fine di essi si è il ricordarsi l'alta mia estimazione per voi, la vostra promessa, e il desiderio con cui vi sto attendendo. Credo inutile avvertirvi che sono opera di un giorno; essi risentono pur troppo della fretta con cui son fatti. Nullameno ardisco pregarvi di dirmene il parer vostro e di notarne i maggiori vizi».
Il giovane poeta è umile e sembra dubbioso riguardo le sue capacità. Si scusa preventivamente degli errori compiuti nella stesura dell’opera e loda il maestro, del cui insegnamento si nota l’influsso stilistico in entrambe le opere qui citate.
La qualità del lavoro del Manzoni è però esaltata del suo interlocutore che così risponde:
«I versi che mi hai mandato sono belli... Rileggendoli, appena scontro qualche parola che, volendo essere stitico, muterei, ed è probabile che non sarebbe che in peggio. Dopo tutto, sempre più mi confermo che in breve, seguitando di questo passo, tu sarai grande in questa carriera, e, se al bello e vigoroso colorito che già possiedi, mischierai un po' di virgiliana mollezza, parmi che il tuo stile acquisterà tutti i caratteri originali».
L’ammirazione del maestro per il suo discepolo non lascia dubbi, il Manzoni già allora era destinato alla grandezza letteraria e il suo punto di forza era la capacità di colpire vigorosamente il lettore attraverso i contenuti delle sue opere.
Due anni dopo, nel 1805, Manzoni si trasferì a Parigi, per coltivare le sue idee razionaliste e libertarie, per crescere come scrittore, ma soprattutto per vivere vicino alla madre, che aveva lasciato lui e il padre poco dopo la sua nascita e con la quale aveva intrattenuto solo rapporti epistolari. Anche se Manzoni aveva già vent’anni, i due recuperarono in fretta il tempo perduto e il loro rapporto fu affettuoso fino alla morte di lei.
A Parigi Manzoni frequentò i migliori salotti della città. Si convinse sempre più che la letteratura, e in particolare la poesia, dovesse avere un profondo valore civile per continuare ad esistere. Dello stesso avviso era Carlo Imbonatti, storico compagno della madre, che diventò protagonista di un’opera del Manzoni, intitolata proprio “in morte di Carlo Imbonatti”. Nella finzione letteraria l’Imbonatti appare in sogno al Manzoni ed esalta la poesia come mezzo per istruire la società. Quest’opera, oltre a riaffermare le istanze libertarie del tempo, difendendo così la madre del Manzoni dalle maldicenze dei benpensanti per essersi legata ad un uomo fuori dal matrimonio, confermò l’idea dell’autore rispetto agli obiettivi e ai limiti della poesia.
 Durante la sua permanenza a Parigi conobbe Claude Fauriel. La loro amicizia durò decenni e fu soprattutto il Manzoni a scrivere all’amico per raccontargli lo sviluppo del suo ideale di letteratura. Per capire l’uomo Manzoni non si può tralasciare il fatto che, nonostante egli sostenesse la necessità del fondamento laico dello stato, gli anni sereni di Parigi, il matrimonio con la sua prima moglie, Enrichetta Blondel, e la frequentazione di ambienti di fede giansenista (teoria religiosa che limitava il libero arbitrio dell’uomo rimettendo il destino della sua anima nelle mani della provvidenza divina), favorirono il riavvicinamento dell’autore alla religione cattolica. La convinzione che il volere di Dio determina il destino degli uomini rappresenta uno dei più celebri topos manzoniani regolando la vicenda dei Promessi in maniera fondamentale. Probabilmente determinò persino la fine dell’amicizia con il Fauriel. Il loro scambio di missive fu intenso fino agli anni ’30 del XIX secolo e terminò bruscamente, sia per l’accentuata divergenza delle posizioni letterarie dei due intellettuali, sia perché l’animo del Manzoni era ormai travolto dalle sue nevrosi e dal dolore per i molti lutti familiari, che solo la fede poteva rendere sopportabili. In un giorno di profonda tristezza, di cui non si conosce la data esatta, il Manzoni diede fuoco alla maggior parte delle lettere del Fauriel e dei suoi scritti giovanili. Tra il poco materiale rimasto è interessante l’estratto di una lettera del 29 gennaio 1821, scritta dal Manzoni all’amico francese. Manzoni aveva tenuto aggiornato il Fauriel riguardo agli sviluppi delle poetiche romantiche milanesi e, in questa lettera, prima lo informa dell’opera del poeta Tommaso Grossi, che stava lavorando ad un poema d’argomento storico, poi che considerava l’ambientazione storica l’unica in grado di mantenere viva la letteratura. Una dichiarazione d’intenti che precede di poco la stesura del “Fermo e Lucia” e che conferma l’andamento del pensiero manzoniano, sempre più distante dal genere poetico considerato falso e destinato ad abbracciare il romanzo, unico mezzo per descrivere “il vero storico”. Durante la sua permanenza a Parigi conobbe Claude Fauriel. La loro amicizia durò decenni e fu soprattutto il Manzoni a scrivere all’amico per raccontargli lo sviluppo del suo ideale di letteratura. Per capire l’uomo Manzoni non si può tralasciare il fatto che, nonostante egli sostenesse la necessità del fondamento laico dello stato, gli anni sereni di Parigi, il matrimonio con la sua prima moglie, Enrichetta Blondel, e la frequentazione di ambienti di fede giansenista (teoria religiosa che limitava il libero arbitrio dell’uomo rimettendo il destino della sua anima nelle mani della provvidenza divina), favorirono il riavvicinamento dell’autore alla religione cattolica. La convinzione che il volere di Dio determina il destino degli uomini rappresenta uno dei più celebri topos manzoniani regolando la vicenda dei Promessi in maniera fondamentale. Probabilmente determinò persino la fine dell’amicizia con il Fauriel. Il loro scambio di missive fu intenso fino agli anni ’30 del XIX secolo e terminò bruscamente, sia per l’accentuata divergenza delle posizioni letterarie dei due intellettuali, sia perché l’animo del Manzoni era ormai travolto dalle sue nevrosi e dal dolore per i molti lutti familiari, che solo la fede poteva rendere sopportabili. In un giorno di profonda tristezza, di cui non si conosce la data esatta, il Manzoni diede fuoco alla maggior parte delle lettere del Fauriel e dei suoi scritti giovanili. Tra il poco materiale rimasto è interessante l’estratto di una lettera del 29 gennaio 1821, scritta dal Manzoni all’amico francese. Manzoni aveva tenuto aggiornato il Fauriel riguardo agli sviluppi delle poetiche romantiche milanesi e, in questa lettera, prima lo informa dell’opera del poeta Tommaso Grossi, che stava lavorando ad un poema d’argomento storico, poi che considerava l’ambientazione storica l’unica in grado di mantenere viva la letteratura. Una dichiarazione d’intenti che precede di poco la stesura del “Fermo e Lucia” e che conferma l’andamento del pensiero manzoniano, sempre più distante dal genere poetico considerato falso e destinato ad abbracciare il romanzo, unico mezzo per descrivere “il vero storico”.
Ecco le parole del Manzoni all’amico Fauriel:
«Riunire i tratti caratteristici di un’epoca della società e svilupparli in un’azione, trarre profitto dalla Storia senza mettersi in concorrenza con essa […]: ecco quel che mi pare ancora concesso alla poesia»
Alla poesia è ancora riconosciuto qualche valore, ma il pensiero manzoniano è ormai irreversibile.
L’ultimo rapporto che analizzeremo è quello tra il Manzoni e Padre Rosmini, che fu beatificato dalla Chiesa per le opere di carità compiute durante la sua vita e si dedicò inoltre agli studi filosofici, favorendo la causa indipendentista italiana. Non risulta difficile capire perché il Manzoni abbia sentito un’affinità intellettuale profonda con questo uomo di fede. Lo scambio di missive iniziò nel ’26, quando Manzoni era ormai uno scrittore affermato e Rosmini ancora un giovane prete. Inizialmente fu il Manzoni ad influenzare il Rosmini, ma con il passare del tempo il religioso divenne una guida spirituale di straordinaria importanza per lo scrittore, il quale nel ‘27 terminò il suo percorso creativo. Da allora si dedicò alla ricerca linguistica e storica per completare i Promessi Sposi. Le uniche due opere pubblicate dopo quella data, oltre all’edizione finale del romanzo , furono l’appendice di esso, cioè “Storia di una colonna infame”, che però è un saggio storico, e “Milano 1821”, stampato dopo le 5 giornate del ’48, ma scritto contemporaneamente ai moti milanesi del ’21. Il Rosmini fu un sostegno fondamentale per l’animo del Manzoni, che nelle lettere confessò tutti i suoi dubbi di uomo, oltre che di letterato. Enrichetta Blondel era morta nel 1833, il suo secondo matrimonio non riempì il vuoto causato dalla perdita della consorte. Molti dei figli del Manzoni morirono e quelli in vita lo fecero probabilmente pentire di non essere stato un genitore severo quanto il padre. Nel 1855 Rosmini morì. Possiamo solo immaginare il dolore per la perdita dell’amico di cui Manzoni aveva detto: «E’ una delle sei o sette intelligenze che più onorano l'umanità». Il carteggio tra i due testimonia come la loro amicizia fu il duplice vertice sublime di unica fiamma, come scrisse nel 1905 il grande poeta Antonio Fogazzaro.
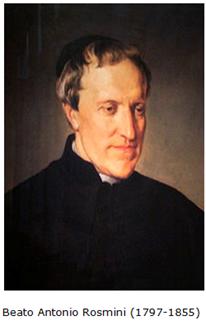
Gli anni successivi all’unità di Italia rappresentarono un paradosso esistenziale per il Manzoni, che era il simbolo della borghesia milanese: uomo di fede, contrario al potere temporale della chiesa, favorevole a Roma capitale (di cui ricevette la cittadinanza onoraria) e senatore del regno d’Italia. I suoi Promessi erano già considerati una tappa fondamentale della letteratura nazionale italiana. L’immortalità della sua parola era cosa fatta. L’uomo però era rimasto solo, senza una famiglia, senza confidenti sinceri.
Generazioni di studenti hanno considerato Manzoni come un noioso borghese intrappolato nella sua opera letteraria, in realtà Manzoni fu un romantico dall’animo tormentato, romanziere, poeta, storico e linguista. Le debolezze di questo grande uomo hanno reso immortale lo scrittore, che proprio nella letteratura cercava la pace dello spirito. |

