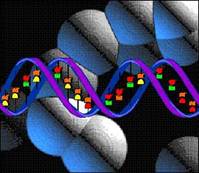 Quando nel febbraio 2001 fu completato il sequenziamento del DNA, i ricercatori si trovarono dinanzi ad alcune grosse sorprese: almeno la metà dei 3 miliardi di basi delle quali era composta la molecola della vita erano ripetizioni casuali, apparentemente non funzionali e superflue; inoltre i geni erano spezzettati, cioè le sequenze con le informazioni per costruire le proteine (esoni, meno del 2% del nostro genoma) erano interrotte da parti (introni, circa il 25%) non utili per questo scopo. Quando nel febbraio 2001 fu completato il sequenziamento del DNA, i ricercatori si trovarono dinanzi ad alcune grosse sorprese: almeno la metà dei 3 miliardi di basi delle quali era composta la molecola della vita erano ripetizioni casuali, apparentemente non funzionali e superflue; inoltre i geni erano spezzettati, cioè le sequenze con le informazioni per costruire le proteine (esoni, meno del 2% del nostro genoma) erano interrotte da parti (introni, circa il 25%) non utili per questo scopo.
Oggi quindi è nota la funzione del solo 2% del nostro DNA, vale a dire di una percentuale che in altri contesti verrebbe ritenuta trascurabile o quasi.
E del restante quasi 98% che cosa si può dire?
Per il passato esso è stato ritenuto privo di alcuna utilità, spazzatura quindi, e normalmente chiamato appunto junk DNA (DNA spazzatura), termine che è stato introdotto nel 1972 da Susumu Ohno. Ma la sola ragione di questo termine è perchè allora si era incapaci di assegnarvi una funzione, verificato che tali sequenze non sono soggette a normale trascrizione in RNA (*) o sono rimosse e allontanate prima di essere tradotte in proteina (*).
Ma nel giugno 2004 un gruppo di scienziati della Harvard Medical School (HMS) dimostrò nel grano che proprio una sequenza del junk DNA regolava l’attività dei geni ad essa vicini; quindi mentre i geni “comuni” hanno come effetto di essere tradotti in proteine, questo gene agiva bloccando, o in generale influenzando, l’attività di altri geni. Dopo questo primo studio pionieristico, molti altri hanno dimostrato che il DNA non-codificante gioca un ruolo vitale nella regolazione dell’espressione degli altri geni facendoci intravvedere una diversa prospettiva secondo la quale non solo questo DNA non è per nulla spazzatura, ma, grazie ai suoi ruoli regolatori, può essere forse la componente più importante dell’intero sistema.
Del resto l’idea che la maggior parte del DNA presente in una cellula potesse essere inutile si scontrava con un concetto basilare della biologia che vede in un organismo un ottimale rapporto introito energetico/spesa energetica. Portarsi dietro un’enorme quantità di molecole non necessarie è contrario a questa caratteristica fondamentale vivente. La costante replicazione di tale grande quantità di informazioni inutili sarebbe, infatti, un grande spreco di energia e ciò naturalmente ha subito acceso il dibattito sul perchè l’evoluzione non avesse provveduto ad eliminarlo.
Da allora più di 700 studi ne hanno dimostrato infatti un ruolo di potenziamento della trascrizione dei geni vicini, oltre 60 ne hanno indicato il ruolo di silenziamento e di soppressione della trascrizione ed alcuni altri ne hanno evidenziato il ruolo regolatore; altri affermano che il DNA non-codificante controlla la trascrizione delle proteine e che riveste un ruolo chiave nella regolazione dell’espressione genica durante lo sviluppo dell’embrione. Questo è il motivo per cui una così grande porzione di genoma non è finita nel cestino evolutivo.
Quindi il DNA non-codificante influenza il comportamento dei geni, cioè del DNA codificante, anche se ancora non sappiamo bene come.
Che cosa conosciamo oggi di quello che mi piace chiamare l’altro DNA?
Certamente esso comprende quelle porzioni, le cosiddette regioni introniche, che vengono trascritte in RNA ma rimosse prima di essere utilizzate per la sintesi proteica. Nel passato alcuni studiosi ritenevano che anche queste non avessero utilità alcuna ma successivamente è stato dimostrato che la loro rimozione a monte, a livello del gene, causa il non funzionamento del gene stesso esattamente come se ad essere rimossa fosse stata una sezione codificante.
Ancora, una componente significativa è costituita dagli elementi ripetuti, sequenze di tre o più nucleotidi reiterata un numero elevato di volte in successione che spesso i genetisti utilizzano per svolgere indagini di tipo filogenetico o di accertamento parentale o ancora per individuare l’eventuale predisposizione a sviluppare una patologia.
In un recente lavoro pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Genetics si conclude come tali sequenze ripetute, che in totale rappresentano ben il 45% dell'intero genoma, rispondano ad un preciso programma genetico e contribuiscano in maniera decisiva a dare un’identità alle diverse cellule dell’organismo umano. Oggi si comincia a capire anche dove vanno ad agire i trascritti di tali sequenze, definendone il loro ruolo che è preciso anche se non comporta sintesi proteica.
Quindi il “lato oscuro” del genoma si comporterebbe esattamente come i geni, come del resto è logico che sia, e queste regioni non codificanti svolgerebbero un ruolo essenziale nel mantenere l’integrità di un organismo e potrebbero chiarire le differenze tra i genomi delle diverse specie.
Come spiegare poi che alcune di queste sequenze presentano una percentuale elevatissima di conservazione tra le diverse specie, anche tra loro lontanissime?
Che origine avrebbe dunque questo DNA non-codificante?
Per quale motivo persisterebbe all’interno del DNA?
A riguardo sono state avanzate numerose ipotesi anche se per il momento nessuna di esse è riuscita a convincere del tutto la comunità scientifica né è stata aprioristicamente scartata; oggi piuttosto l’orientamento è quello di ritenere che esso si sia originato in diversi modi.
Alcune di queste ipotesi tra le più accreditate suppongono che si tratti di geni che, nel corso dell’evoluzione, avrebbero perso la loro funzione probabilmente perché si sarebbe frammentata la corretta sequenza per opera di agenti interferenti anche di origine ambientale.
Altre propongono una semplice funzione protettiva nei riguardi delle porzioni codificanti del DNA che è una molecola sottoposta continuamente a danneggiamenti di natura fisica (radiazioni) e chimica: la presenza di tali elevate percentuali di non coding-DNA lo renderebbe statisticamente il bersaglio più frequente dell’aggressione, proteggendo le porzioni codificanti.
Altri ancora suggeriscono un ruolo di riserva di sequenze dalle quali potrebbe emergere, in una determinata nuova condizione ambientale, un nuovo gene capace di conferire vantaggio evolutivo all’organismo.
Semplicisticamente alcuni ritengono il junk DNA un elemento spaziatore tra i vari geni che consentirebbe agli enzimi della trascrizione di lavorare più agevolmente.
Ricercatori della Yale University School of Medicine, del Berkeley National Laboratory in California, del Genome Institute a Singapore e del Medical Research Council britannico hanno effettuato un'analisi comparata dei genomi di uomo, scimpanzé, macaco e altri primati concludendo che la nostra evoluzione potrebbe esser dovuta a cambiamenti non solo nelle sequenze di DNA codificante, ma anche a variazioni di altre regioni del genoma che agiscono come interruttori dell’espressione genica e che il più delle volte non si trovano nemmeno nelle regioni limitrofe al gene su cui agiscono.
Tra queste i ricercatori hanno, per es., approfondito lo studio della sequenza HACNS1 umana e quelle ad essa correlate nelle altre specie. La sequenza umana, durante la vita fetale, attiva i geni correlati allo sviluppo degli arti ed in particolare gli schemi per la formazione del pollice e dell’alluce.
Il risultato fornisce una prova iniziale del fatto che cambiamenti funzionali nella sequenza HACNS1 possono avere contribuito in misura decisiva all'adattamento del piede, dell'anca, dell'avambraccio e della mano alla stazione eretta ed alla deambulazione bipede nell’uomo rispetto alle altre specie.
Queste sequenze non-codificanti sono dunque importanti; ne è prova il fatto che sono rimaste quasi invariate anche in specie piuttosto distanti fra loro, come l'uomo e la gallina. Recentemente sono stati individuati circa 500 elementi ultraconservati nei genomi di tutti i viventi studiati, proprio all’interno del DNA spazzatura.
In generale si può dire che le sequenze che hanno una funzione vengono conservate, ovvero si modificano poco tra i diversi organismi durante il processo evolutivo e tra queste ci sono quelle che servono a codificare proteine che sono molto simili nelle diverse specie.
Ma il fatto sorprendente è che esistano anche sequenze estremamente conservate a funzione ignota.
Alcuni recenti studi mettono in evidenza come sia proprio a livello di junk-DNA che si diversificano le varie specie che peraltro sarebbero molto simili tra loro per quanto riguarda il DNA codificante.
Se ne potrebbe dedurre che non è tanto il numero di geni quanto il loro funzionamento e come sono regolati a rendere l'uomo uomo, il gatto gatto, la scimmia scimmia.
Il DNA, molecola della vita, non è in fondo che una formula di codifica per la sopravvivenza, presente in tutte le cellule. Quando noi nasciamo indubbiamente non siamo solo un corpo ma siamo esseri complessi dotati di istinto, di abilità, di sentimenti. Ci aspettiamo che anche queste caratteristiche, così come la morfologia e la fisiologia del nostro organismo, siano codificati nel DNA di quella cellula primigenia dalla quale deriva l’intero nostro organismo. Forse proprio nel DNA-spazzatura sono programmati istinto e comportamento, forse proprio nell’altra faccia della luna si nascondono le risposte più intriganti.
(*) vedi articoli precedenti della stessa autrice
|

